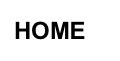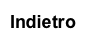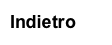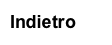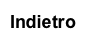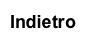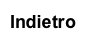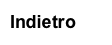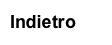I. Le radici del conflitto
La crisi del Kosovo affonda le sue radici in un passato lontano. Le cause profonde dello scoppio di tale crisi sono di natura storica, culturale ed etnica. La complessità e la particolarità di questi fattori influenzeranno il modo in cui verrà gestita la prima fase della crisi da parte degli attori internazionali fino all’intervento della Nato. Le controverse giustificazioni della guerra e la risoluzione che ne seguirà costituiranno la cornice di fondo in cui verrà avviata la missione dell’Onu. Le ambiguità giuridiche su cui si baserà tale missione e la disputa sullo status del Kosovo causeranno, a loro volta, il fallimento del progetto internazionale di stabilizzazione attraverso una ricostruzione istituzionale guidata. La dichiarazione di indipendenza del febbraio 2008 segna di fatto il fallimento della missione e l’inizio di una terza fase, in cui risaltano tutti problemi interni ed esterni che ne avevano evidenziato l’inefficacia. Dunque partiamo dall’inizio, dalle cause profonde alla base della crisi.
1. Kòsovo o Kosòva. Due versioni della stessa storia
1.1 Demografia e nazionalismo: i concetti teorici alla base del conflitto
Il Kosovo è una regione situata nella parte sud della Serbia, al confine con Albania e Macedonia. Ha una superficie di circa 10.000 Km² e conta una popolazione di circa 2.000.000 di persone che abitano per lo più in zone rurali e in piccole comunità di villaggio. La capitale Priština è abitata da poco più di 500.000 kosovari. I gruppi etnici presenti sul territorio sono: albanesi per circa l'88%, serbi per circa il 7%, e i restanti sono rom e piccole comunità di bosgnacchi. Gli albanesi sono per il 96% musulmani e per il 4% cattolici. I serbi sono, nella quasi totalità, cristiani ortodossi.
In primo luogo il dato demografico è la chiave per comprendere le giustificazioni date di volta in volta, sia da parte serba che da parte albanese, riguardo alle rivendicazioni territoriali. Dunque è bene analizzare brevemente alcune fasi salienti della storia per meglio comprendere le vicende contemporanee. A partire dal VII secolo d.C. gli Illiri, da cui discendono gli albanesi e che per secoli avevano resistito al dominio romano e bizantino, si videro costretti a convivere con i popoli slavi protagonisti, in quell'epoca, di grandi ondate migratorie da nord. Questi ultimi riuscirono a imporre la loro egemonia sugli Illiri, fino alla storica battaglia di Kosovo Polje del 1389 dalla quale gli slavi, in maggioranza serbi, uscirono sconfitti contro il potente Impero Ottomano. Da quel momento in poi, mentre i serbi mantennero molto fieramente la loro identità cristiano-ortodossa, molti albanesi si convertirono all'Islam, senza però dimenticare le loro origini culturali basate sulle regole del Kanun, cioè un codice di consuetudini tribali compilato dal leader cristiano (anti-ottomano) Lek Dukagjini. Tuttavia è fondamentale sottolineare il fatto che questa conversione di massa rispondeva più a opportunità di tipo fiscale, che gli ottomani concedevano a chi si convertisse all'Islam, che a vocazioni di tipo spirituale. Successivamente, intorno al 1690, le popolazioni serbe non convertite, che ormai non erano più in grado di sopportare il peso delle angherie subite, cominciarono un lento ma inesorabile esodo verso nord, lasciando spazio per un ripopolamento degli albanesi che si muovevano da ovest verso est. Un 'altra ondata migratoria serba si può registrare tra il 1735 e il 1739. Arriviamo così agli inizi del XX secolo. Da questo momento in poi la popolazione albanese sarà sempre in maggioranza in Kosovo, prima con percentuali più basse ma via via in costante crescita. In particolare la sproporzione è netta a partire dal secondo dopoguerra, a causa delle emigrazioni dei serbi e di un'alta natalità fra gli albanesi: nel 1948 i serbi costituiscono il 27,5% della popolazione del Kosovo e saranno sempre meno nel corso degli anni. Infatti mentre gli albanesi crescono dal 67,2% del 1961 al 77,4% del 1981 fino ad arrivare a quasi il 90% nel 1991 (anche se quest'ultimo dato è approssimativo in mancanza di un censimento ufficiale dell'epoca), la popolazione serba passa dal 18,4% del 1961 al 13,2% del 1981 fino a circa il 10% nel 1991.
In secondo luogo, è fondamentale definire concettualmente altri tre fattori che stanno alla base delle rivendicazioni di serbi e albanesi: il concetto di etnia, di nazionalità e di religione. Partendo da quest'ultimo possiamo dire che è uno dei caratteri discriminanti delle diverse genti che abitano i Balcani. Sarebbe però un errore mettere in primo piano l'aspetto religioso come causa degli attriti e delle tensioni che caratterizzano questa regione. Infatti la contrapposizione si basa principalmente su criteri di appartenenza etnica, alla quale ovviamente è legata una confessione religiosa. Per capire la complessità delle ragioni storiche alla base della guerra del Kosovo (cosi come la guerra in Bosnia) è necessario insistere su questa nozione di etnia. Innanzitutto la categoria etnica si fonda su un principio artificioso basato su una rappresentazione della realtà soggettiva e non scientifica, da cui deriva la concezione della propria identità, che porta a costruire dei miti, dei simboli, una storia, una memoria, una tradizione nei quali poi il popolo si riconosce per condivisione. Solo in un secondo momento, nella storia della Jugoslavia, il fattore religioso è stato utilizzato come elemento di distinzione tra le etnie. Così i serbi sono gli ortodossi, i croati sono i cattolici, gli albanesi sono i musulmani, e poi ci sono i bosniaci ( cioè gli abitanti della Bosnia Erzegovina) e i bosgnacchi ( boŝnjak, cioè appartenenti all'etnia e nazionalità bosniaco-musulmana). Insomma in Jugoslavia, che letteralmente significa “terra degli slavi del sud”, le varie differenze religiose e di sviluppo socio-economico, che si sono delineate nel corso della storia, sono state erroneamente e strumentalmente definite “identità etniche”. Inoltre è importante sottolineare come il sentimento nazionalista, che pare essere il motore di molte rivalità della regione, in realtà sia anch'esso il frutto di una strumentalizzazione di differenze a livello sociale e religioso. Il caso di Sarajevo è emblematico: questa era infatti l'unica grande città della Bosnia, aperta alle influenze che vengono sia da occidente che da oriente, una vera città cosmopolita. I suoi abitanti si sentivano (prima della guerra del 1992-1995) prima di tutto sarajevesi, poi bosniaci, men che meno jugoslavi. La differenziazione era tra il borghese musulmano e il contadino serbo-ortodosso. Da qui nasce l'idea di diversità etnica. Ciò si traduce in seguito in violento nazionalismo per il fatto che cresce la consapevolezza di appartenere ad uno stato, la Jugoslavia, che non coincide con la propria idea di nazione, e cioè l'insieme di tutti gli individui che praticano un certo culto religioso e al quale si associa erroneamente un'idea di purezza etnica. Questo sentimento valeva per tutti i popoli che facevano parte della Federazione: sloveni, macedoni, croati, bosniaci musulmani, albanesi, montenegrini, ma anche per molti serbi. Così, come spesso accade, il “nazionalismo” verrà utilizzato per fini politici. Infatti dal 1989, il presidente jugoslavo Milošević, con totale demagogia e opportunismo, istigherà ancor più le tendenze nazionalistiche, sfruttando il fattore Kosovo in modo propagandistico, semplicemente per assicurarsi il consenso dei serbi e mantenere il potere. Così facendo non si renderà conto di aver accelerato un processo ormai irreversibile: il fallimento dell'esperimento jugoslavo e l’inesorabile smembramento della Federazione.
In terzo luogo, è fondamentale capire le posizioni e le motivazioni di serbi e albanesi che stanno alla base delle reciproche rivendicazioni territoriali. Prima di tutto va fatta una specificazione. Nonostante gli albanesi nella Repubblica Federativa Socialista di Jugoslavia (SRFJ) siano sempre stati una forte minoranza, molto più consistente ad esempio degli sloveni o dei montenegrini, a differenza degli altri gruppi etnici non si sono mai visti accordare lo status di Repubblica. Dunque, come detto, questa è una terra dal forte valore simbolico per entrambi i popoli. I serbi la chiamano Kòsovo e Metohija o Kosmet e lo considerano la culla della propria gloriosa civiltà. Per gli albanesi invece, quello che loro chiamano Kosòva, rappresenta da sempre la speranza dell'indipendenza. Infatti se per i serbi rappresenta il luogo dove avvenne la storica battaglia di Kosovo Polje nel 1389 contro l'invasore ottomano, per gli albanesi rappresenta la propria casa, abitata per secoli dai propri avi, dato che si considerano i primi abitanti del Kosovo in quanto discendenti degli Illiri. Dunque se la presenza di migliaia di centri di culto cristiano-ortodossi sparsi sul territorio è la prova della sacralità di questa regione per l'etnia serba, da parte albanese il territorio è vissuto come qualcosa di reale e di materiale, un elemento fisico in cui nascono e si sviluppano le proprie relazioni sociali. Il nazionalismo albanese nasce non tanto dal fattore religioso-culturale quanto dall'idea di nazione kosovara legata a dei confini fisici territoriali; solo in seguito, per via della grossa sproporzione demografica, alla quale non corrisponderà adeguata rappresentanza a livello istituzionale, verrà aggiunta la connotazione etnica, dalla quale,ovviamente, saranno esclusi i serbi kosovari. Il nazionalismo serbo, strumentalizzato dalla politica negli anni '80, oltre che coincidere con il carattere religioso-culturale, è il frutto anche di un'errata percezione di quello che realmente accadeva in Kosovo. Il cittadino serbo medio era, in quel periodo, una vera e propria vittima della disinformazione e della faziosità delle propagande mediatiche che venivano fatte a discapito degli albanesi kosovari. Tutto questo ci fa capire come i germi del nazionalismo, già presente a molti livelli della società (soprattutto tra i militari e le forze di polizia), siano stati coltivati abilmente e strumentalmente dalla politica. Gli effetti maggiori saranno visibili solo una decina d'anni più tardi, quando ormai sarà troppo tardi.
In ultima analisi possiamo quindi affermare che sia da una parte che dall'altra i sentimenti, già forti, di rivendicazione e di riscatto sono stati sfruttati in modo demagogico e artificioso, e che per entrambi la rivendicazione territoriale è causa e obiettivo della controversia. A seconda delle fasi storiche, albanesi e serbi sono stati vittime o carnefici. Infine per riassumere il marasma etnico-culturale in cui vessa la regione della ex Jugoslavia basti tenere a mente una celebre frase dello storico inglese Hugh Seton Watson:”I popoli balcanici producono più storia di quella che riescono a consumare”.
1.2 Dalla Jugoslavia di Tito alla Serbia di Milošević
Riprendendo il filo degli eventi si arriva agli inizi del XX secolo, allorché il decadimento dell'Impero Ottomano diede modo ai serbi, che per secoli erano stati sottomessi, di aspirare a creare un grande Stato che riunisse tutti i popoli slavi dei Balcani meridionali. Fu così che, in seguito alle guerre balcaniche (1912-1913), la neonata Serbia ingloba una buona parte del Kosovo, lasciando però l'area occidentale (che essi chiamano Metohjia e gli albanesi Dukagjini) al Regno del Montenegro. I nazionalisti albanesi aspirano anch’essi a creare uno Stato kosovaro, ma il tentativo viene soffocato sul nascere dall'espansionismo serbo. Solo nel 1946 la Jugoslavia del maresciallo Tito dichiara il Kosovo regione autonoma e nel 1963 provincia autonoma. Tuttavia per tutti gli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta gli albanesi sono stati vittime di feroci discriminazioni e rastrellamenti arbitrari da parte della polizia federale guidata dall'allora Ministro federale degli Interni Aleksandar Ranković. Quello fu un periodo nero nella storia degli albanesi kosovari, che addirittura arrivarono al punto da acquistare armi da consegnare ai poliziotti durante le perquisizioni per evitare maltrattamenti. Nel 1966 Tito decide che la stagione del pugno di ferro è finita e che bisogna trovare altri modi per stabilizzare il Kosovo. Innanzitutto depone Ranković. Successivamente, in seguito agli avvenimenti di Praga del 1968 che scuotono un po' tutta l'Europa centro-orientale, il maresciallo cerca un accordo con l'Albania, da cui scaturisce una cooperazione a livello culturale con l'apertura delle università kosovare ai docenti di Tirana. Questo permette la nascita di nuove leve albanesi che andranno a ricoprire importanti cariche nell'amministrazione, nella magistratura, negli organi istituzionali locali, nell'economia ma soprattutto nelle file delle forze di polizia kosovare, che nel 1981 saranno composte per tre quarti da albanesi. Ma la svolta si ha nel 1974 quando Tito con la nuova Costituzione, concede al Kosovo lo status di Provincia Federale e con esso un ampia autonomia, che comprende poteri legislativi e un peso negli organi federali equivalente a quello delle Repubbliche. L'unico diritto di cui era privo era la possibilità di secessione dalla Federazione ( poiché gli albanesi in Jugoslavia sono sempre stati considerati una minoranza e non popolo costitutivo).
Nel 1980, con la morte di Tito, avrà inizio la dissoluzione della SRFJ e con essa uno stato che aveva nel multinazionalismo un carattere distintivo. Si può dire che il motto su cui si fondava la Jugoslavia di Tito, “Serbia debole, Jugoslavia forte”, fosse in netta contrapposizione con la prima esperienza federale, nel periodo tra le due guerre, che voleva una “Serbia forte, Jugoslavia forte”. Ma dal 1981 le cose cambiano. Ci si accorge che il sistema titino in realtà non è poi così coeso, tant'è che comincia a mostrare i primi segni di cedimento. D'ora in avanti i leader serbi spingeranno in senso contrario, ossia sul nazionalismo e il senso di frustrazione dei serbi del Kosovo. Per tutti gli anni Ottanta verrà diffusa in Serbia una campagna mediatica anti-albanese sostenuta da molti intellettuali, giornalisti e politici. Insomma una vera e propria opera di diffamazione, in parallelo con l’esaltazione dello spirito del popolo serbo, la cui dimensione temporale non corrisponde a quella spirituale.
Fatto sta che sull'onda del nazionalismo riuscì a farsi strada l'uomo che porterà la Serbia e tutta la Jugoslavia verso la rovina, il banchiere ed ex tecnocrate comunista Slobodan Milošević. Questi si accorge subito della forza propagandistica ed elettorale del richiamo nazionalistico, e, grazie proprio all' acquisito consenso popolare e al carisma dimostrato all'interno del partito, riesce ad ottenere i pieni poteri alla fine del 1987. Liquidato l’allora presidente serbo Ivan Stambolić, in meno di un anno riesce a rovesciare i governi di Vojvodina e Montenegro, istallandovi i propri protetti. Prossimo obiettivo: togliere l'autonomia al Kosovo. Il 23 marzo 1989 l'Assemblea del Kosovo approva (senza la maggioranza legale) degli emendamenti alla Costituzione del 1974, annullando le autonomie della Provincia nell’ambito della Repubblica di Serbia.
Esplode la protesta albanese alla quale la polizia risponde duramente. È l'inizio dell'inferno kosovaro. Cominciano gli arresti arbitrari a politici, intellettuali, giornalisti, medici, dirigenti d'azienda, funzionari. Ritornano le torture nelle carceri, interrogatori senza accuse formali, pestaggi, e chi più ne ha più ne metta. Così ha inizio la vicenda kosovara, con l’indifferenza e l’incapacità dell’Europa di far fronte a una crisi in casa propria.
2. La guerra latente: 1989-1998
Chiarite le origini profonde della crisi possiamo ora entrare nel pieno della questione, partendo dalle cause scatenanti che hanno portato alla guerra del 1999, per arrivare alla missione dell’Onu, simbolo di un progetto internazionale unico nel suo genere.
2.1 Underground Kosovo: la non-violenza di Rugova. 1989-1995
Tra il marzo e il giugno del 1990 i parlamenti serbo e jugoslavo approvano un serie di leggi fortemente discriminatorie verso gli albanesi: soppressione dell'Accademia delle scienze e delle arti del Kosovo, licenziamenti dei docenti, allontanamento di medici e giornalisti, discriminazioni sostanziali nel settore pubblico e nelle aziende private, sostituzione degli albanesi nelle alte cariche dell'amministrazione, della magistratura, dell'informazione, il sistema scolastico viene bloccato con la serbizzazione a ogni livello dell'istruzione, agli albanesi viene fatta studiare la storia che afferma la loro discendenza dagli slavi.
Rimane solo un ostacolo istituzionale al progetto di Milošević: l'Assemblea provinciale, dove gli albanesi hanno la maggioranza. Ma il 2 luglio, giorno in cui era in programma la votazione per una riforma costituzionale, la sede era chiusa. I delegati albanesi allora votano per strada una risoluzione che stabilisce “l'entità paritaria e indipendente nella federazione jugoslava”. Per tutta risposta il parlamento serbo scioglie l'Assemblea e il governo del Kosovo. Il 7 settembre 1990 i deputati albanesi approvano una nuova Costituzione del Kosovo (confermato da un referendum plebiscitario dal 99,87% dei votanti), e il 22 settembre del 1991 approvano una risoluzione per l'indipendenza e la sovranità del Kosovo. Infine il 19 ottobre 1991 il Parlamento dichiara la Repubblica del Kosovo. Da questo momento gli albanesi mettono in moto, con grande volontà e forza d'animo, una società sotterranea, parallela alle istituzioni ufficiali, monopolizzate dai serbi. Parlamento, governo, scuole, università, circoli sportivi, istituti culturali, media in lingua albanese, un vero e proprio sistema sanitario parallelo. È così che inizia una nuova stagione di violenze alla Ranković, ma forse peggio, con carcerazioni arbitrarie, rastrellamenti, perquisizioni a tappeto, maltrattamenti, ricatti e ritorsioni, in qualche caso anche uccisioni. Per anni gli albanesi subiscono in silenzio uno stillicidio di uccisioni, discriminazioni e violenze diluite giorno dopo giorno, nella speranza che l'Occidente si accorga di loro, dell'effettiva esistenza di una società che aveva scelto, per paura di pesanti ritorsioni ma anche per seguire fiduciosamente il progetto politico di un uomo, la strada della non-violenza. Ma la sorte non è dalla loro parte; la comunità internazionale e l'Europa in particolare è troppo presa dall'attuale emergenza Bosnia. I kosovari rimangono nell'ombra ancora per molto. Per l'Occidente non ci sono ancora abbastanza morti e la politica della non-violenza non ha un impatto mediatico rilevante. Se non altro perché i serbi sono a conoscenza e “tollerano” lo svolgimento di talune attività semi-clandestine.
Riguardo a quest'ultimo punto è doveroso ricordare che anche nella Jugoslavia di Tito esistevano tali istituzioni, legittime, che effettivamente operavano sul territorio. In realtà dunque non è stato creato niente di nuovo. Prendiamo ad esempio il principale partito albanese, la Lega Democratica del Kosovo (Ldk), che si pone come guida in questa politica della non-violenza. Questo esisteva sin dai tempi di Tito come Lega socialista del Kosovo. Tuttavia ufficialmente la Ldk nasce il 23 dicembre 1989 ed è guidata da associazioni di scrittori ( Pen Club) e di filosofi. Il cuore del partito è formato dal professore e scrittore Rexhep Qosja, dal poeta e professore di letteratura Ibrahim Rugova, dal sociologo Fehmi Agani, dal chirurgo Bujar Bukoshi. Quest'ultimo diventerà primo ministro del governo kosovaro in esilio, mentre Rugova sarà scelto come leader. Infatti nelle elezioni, che si tengono il 24 maggio 1992, la Ldk ottiene il 76% dei voti e Rugova un ampio consenso come Presidente della Repubblica. I lavori del Parlamento però sono ostacolati da Belgrado, mentre un esecutivo di sei ministri (tra cui Istruzione, Finanze, Sanità ma non Difesa e Interno) è costretto a risiedere in esilio a Bonn. Ma le tensioni si riaccendono in occasione delle elezioni jugoslave alla fine del 1992. Gli albanesi commettono un grave errore non sostenendo il premier della Federazione Milan Panić, che si candidava come presidente jugoslavo in alternativa a Milošević, determinando la vittoria di quest’ultimo. Il boicottaggio albanese provoca ulteriori ripercussioni. Fra il 1993 e il 1995 vengono processati centinaia di ex poliziotti e ufficiali dell'esercito jugoslavo, di nazionalità albanese, accusati di sostenere e finanziare vari gruppuscoli armati che si preparano per eventuali insurrezioni. Tra l'altro pare che si stiano organizzando alcuni piccoli gruppi armati finanziati di proventi dei traffici illeciti, ma anche da Bukoshi, che darà vita alle Forze armate della Repubblica del Kosovo (Fark), che alla fine confluiranno anch'esse nei ranghi dell'Uçk.
Gli anni che vanno dal 1989 al 1995 rappresentano, per gli albanesi kosovari, un'esperienza terribile, di sopruso e di violenze, di totale insicurezza, ma anche di straordinaria caparbietà nella resistenza passiva. La non-violenza che professa Rugova e il modo con cui gli albanesi gestiscono le loro istituzioni parallele sono indice di un gran senso di coesione civile e solidarietà sociale. I kosovari sono fin troppo speranzosi che l'Occidente, così evoluto politicamente, si curi di loro. Il colpo di grazia viene dato con gli accordi di Dayton nel novembre del 1995 andando ad aumentare ancor più il senso di frustrazione. Durante i negoziati infatti il Kosovo non viene neanche nominato. Da quel episodio Milošević ne esce come il pacificatore dei serbo-bosniaci, e segna la sconfitta della non-violenza di Rugova. Nel trattato di pace viene riconosciuta la Jugoslavia di Milošević, composta da Serbia e Montenegro. E il Kosovo? Rimane una provincia entro i confini serbi.
Per i kosovari è la fine, non ci sono più vie di uscita. Nessuno si è accorto che la “guerra non combattuta” sta per esplodere.
Tuttavia, come dice giustamente Ventura, se gli albanesi piangono, i serbi non ridono. Infatti le politiche discriminatorie di Milošević non hanno ancora portato a niente. Gli albanesi sono sempre in Kosovo, più fieri che mai, con un tasso di natalità altissimo. Lo dimostrano alcuni dati demografici: nel periodo 1948-1991 la popolazione in Serbia è aumentata del 40%, in Vojvodina del 23%, mentre in Kosovo del 167%. Questo fenomeno ha rimescolato le proporzioni tra le diverse aree della Jugoslavia: ora il Kosovo include circa il 20% della popolazione. Inoltre si può dire che ormai nella provincia, alla fine del 1995, le due etnie vivono in una situazione di reciproco apartheid. I circa 200.000 serbi kosovari sono “segregati” per lo più nella zona nord, al confine con la Serbia, in particolare nella città di Mitrovica.
Alla luce di queste evidenze sono emerse voci contrarie anche tra i serbi. Prima fra tutti l'Accademia serba delle arti e delle scienze che, tramite il presidente Despić, lancia un appello nel 1996 riguardo l'inarrestabile crescita demografica albanese. L'unica via praticabile, a detta dell'accademico, è la spartizione della provincia. Nel 1998 un altro appello, questa volta tramite la pubblicazione di un libro, “Kosovo: avoiding another Balkan war”, al quale collaborano intellettuali e politici sia serbi che albanesi.
Ma dal 1996 si passerà a una fase successiva. Dalla non-violenza, alla guerriglia a oltranza.
2.2 L'Uçk e la guerra non combattuta. 1996-1998
Il panorama politico kosovaro è sempre stato un marasma di partiti, associazioni e coalizioni protagonisti di alleanze e intese molto malleabili. Può succedere che da un giorno all’altro due importanti esponenti passino da alleati nello stesso partito ad avversi in partiti rivali. Tuttavia basti tener presente che, a partire dagli anni ’90, i più importanti attori interni sono, oltre alla Ldk di Rugova, l’Uçk e il suo corrispettivo politico Lpk (Movimento popolare del Kosovo). Quest’ultimo nasce nel 1993, come successore del Lprk (Movimento popolare per la Repubblica del Kosovo). Una parte si stacca per creare il Movimento nazionale per la liberazione del Kosovo (Lkck). Mentre quattro uomini (Veseli, Hasim Thaci, Haliti e Xhuka) daranno vita all'Ushtria Çlirimtare e Kosoves (Uçk), Esercito di liberazione del Kosovo. L'Uçk nasce quindi come braccio armato del Lpk. La differenza sostanziale tra quest'ultimo e la Ldk è la concezione geopolitica del Kosovo. Infatti se per entrambi lo status di indipendenza, o ampia autonomia, rappresenta l'obiettivo principale, Lpk mira alla fusione con le varie comunità albanesi sparse in Montenegro, Macedonia e Serbia, in una sorta di Grande Kosovo da annettere all'Albania o da mantenere in Jugoslavia con una sostanziale autonomia.Ma ciò che è difficile, per gli attori esterni, è trovare un interlocutore stabile e affidabile a livello politico. I due protagonisti principali delle vicende kosovare nel periodo 1989-1999, Rugova con il suo Ldk e l'Uçk, sono portatori di due concezioni opposte riguardo ai metodi da utilizzare per contrapporsi a Belgrado, e l'esito degli accordi di Dayton porta al prevalere della guerriglia, che ottiene l’attenzione internazionale, e soprattutto il sostegno degli Stati Uniti. Dalla fine del 1995 la crisi entra in una nuova fase. L’Uçk si sta preparando a colpire con la violenza mettendo fine al silenzio della resistenza passiva di Rugova.
Nel febbraio 1996 cominciano le prime dimostrazioni di forza, seguite da un appello dei militanti alle organizzazioni internazionali e agli Stati Uniti affinché si ponga fine al regime di occupazione serba e al riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo. Per due anni l'Uçk compie azioni di guerriglia uccidendo un trentina tra poliziotti e collaborazionisti albanesi. Gli attacchi sono appunto volti a colpire bersagli precisi. Nel frattempo, all'estero, esponenti del governo in esilio e dell'Uçk operano per vie parallele. Del resto pure i kosovari hanno smesso da tempo di credere nell'efficacia della resistenza passiva; essi sono sicuramente ancora con Rugova, ma allo stesso tempo approvano e appoggiano le azioni dell'Uçk.
Si arriva così al 1998, quando inizierà la discesa verso la crisi del Kosovo e entro un anno verso una nuova guerra balcanica. Tra il 28 febbraio e il 6 marzo si consuma una strage da parte della polizia serba che attacca due villaggi colpevoli di aver dato appoggio logistico ai guerriglieri. I morti civili sono in totale 84. Le immagini di questi episodi, che verranno ricordati come strage di Drenica, fanno il giro del mondo e l'opinione pubblica ne rimane inorridita. Soprattutto in Europa ci si chiede come, sulla soglia del Ventunesimo secolo, possano avvenire ancora crimini di una tale barbarie ed efferatezza, tanto più nel cuore di un continente che vuole mandare al mondo un immagine di sé come il posto più civile ed evoluto del pianeta. Ormai l'Europa non può più stare a guardare.
Tuttavia la prima risposta significativa arriva dagli Stati Uniti, con il segretario di stato Madeleine Albright che lancia un chiaro monito a Milošević dicendo che ormai hanno imparato la lezione della Bosnia e che non esiterebbero a intervenire se ce ne fosse bisogno. Per lo meno pare che la comunità internazionale si sia accorta del Kosovo. É guerra aperta e il conflitto si è finalmente internazionalizzato.
Nel frattempo le istituzioni parallele albanesi continuano a lavorare, e alle elezioni del 22 marzo 1998 Rugova viene confermato come guida politica. Tuttavia, come detto, le principali speranze vengono ormai riposte nelle lotta armata dell'Uçk. E non solo da parte dei kosovari, ma anche degli Stati Uniti che cambiano completamente atteggiamento nei confronti della guerriglia. Se infatti nel 1996 il fenomeno era stato bollato come movimento sovversivo terroristico, nel 1999, in piena campagna aerea della Nato, i vertici americani affermeranno l'importanza di sostenere l'Uçk, anche a scopo di rendere vani i finanziamenti illegali.
Dunque dal 1998 ormai il conflitto è reale; tutte le tensioni, da una parte e dall'altra, vengono liberate e si assiste a scontri aperti tra polizia serba e guerriglieri. All'estero si comincia a parlare non più solo di apartheid o violazioni dei diritti umani, ma di vera e propria emergenza umanitaria. Intanto le tensioni jugoslave aumentano in occasione delle elezioni in Montenegro, in maggio, che vedono il trionfo del filo-occidentale Djukanović.
In questo contesto comincia il lavoro dei diplomatici americani, primo fra tutti l'ambasciatore Richard Holbrooke, affiancato da Cristopher Hill, ambasciatore in Macedonia. Per tutto giugno e luglio 1998 Holbrooke si sposta tra Mosca, Belgrado e Pristina. Ma la via verso il fallimento della diplomazia sarà breve. Nel giro di pochi mesi rimarranno ben poche alternative alla guerra.
2.3 Il fallimento della diplomazia
Gli Stati Uniti prendono in mano le redini del gioco diplomatico. Infatti l'incapacità europea di rispondere in modo adeguato alla crisi si traduce in appello dei governi alla messa in moto della macchina Nato. In settembre il segretario generale, Javier Solana, annuncia che sono pronti i piani d'intervento dell'Alleanza. Il giorno 24 si procede con un azione di ricognizione aerea ai confini del Kosovo. Ma questa dimostrazione di forza non è percepita da Milošević come una reale minaccia. Infatti - nonostante l'approvazione della risoluzione 1199 da parte del Consiglio di Sicurezza (con l'astensione della Cina), che chiede la cessazione delle ostilità - per tutto il mese di settembre si continua a combattere, e le vittime aumentano sempre più, sia da una parte che dall'altra. Le stragi della polizia serba continuano a colpire le famiglie dei guerriglieri, ma anche civili inermi dei villaggi ritenuti responsabili di aver dato appoggio logistico ai militanti dell'Uçk. Sullo sfondo di questi scontri pareva proprio delinearsi un progetto politico più ampio, una vero e proprio piano di bonifica etnica, che tuttavia raggiungerà il massimo grado di violenza durante quella guerra che era volta proprio a evitare tale orrore.
Nel frattempo giuristi e esperti americani si mettono all'opera per cercare dei cavilli legali che permettano alla Nato di intervenire anche senza autorizzazione del Consiglio di Sicurezza. Al riguardo l'8 ottobre si tiene una riunione dei ministri degli Esteri europei, degli Stati Uniti e della Russia. Quest'ultimo, appunto, dice che se la questione verrà portata in seno al Consiglio di Sicurezza la Russia porrà il suo veto e aggiunge:”Se non la porterete, noi faremo molto rumore”. Solo rumore dunque. Questo è un chiaro segnale che la Russia non può fare niente; certamente non assomiglia neanche lontanamente all’Unione Sovietica.
I piani d'attacco sono pronti. Holbrooke e il generale dell'aviazione americana Short si recano a Belgrado per incontrare Milošević. A questi si chiede il ritiro delle forze serbe fino ai livelli precedenti le ostilità, insieme alla presenza di osservatori sotto l'egida della Nato e dell'Osce, e l'avvio di negoziati con la parte albanese sul futuro della regione. Gli Stati Uniti, sebbene reticenti nel sostenere l'Uçk, erano sicuramente decisi a porre fine alle stragi ma anche convinti a non riconoscere l'indipendenza del Kosovo. Così si dà inizio alla Kosovo Verification Mission (Kvm), guidata dal diplomatico americano William Walker, formalmente rispondente all'Osce.
Ma gli scontri continuano. La polizia serba continua a fare stragi. L'accordo Holbrooke-Milosevic era destinato a fallire già in partenza. Infatti il Kvm, essendo una missione essenzialmente disarmata, non ha alcun effetto di deterrenza ed è fortemente limitata nella capacità di controllo del territorio. L'altro punto debole dell'accordo è rappresentato dall'assenza al tavolo negoziale dell'altro attore chiave, l'Uçk.
Ma un'ulteriore colpo alla pacificazione del Kosovo arriva il 15 gennaio 1999. Quel giorno infatti furono trovati nei pressi di Raćak, un villaggio a due ore da Priština, circa quaranta corpi, anche con orribili mutilazioni, sparsi per la campagna lungo il letto di un fiume. Walker accusa subito le forze serbe di aver compiuto un massacro di contadini inermi. Questa presa di posizione contro una delle parti in causa, di certo non consona a un diplomatico nel ruolo di arbitro super partes, provoca un incidente diplomatico con la Serbia che dichiara Walker persona non grata e ne chiede l'espulsione, che tuttavia verrà in seguito revocata.
La Serbia ora ha problemi ben più impellenti da risolvere. Ormai si trova con le spalle al muro; da una parte deve fronteggiare la pressione sempre più forte degli Stati Uniti e dell'Europa Occidentale che chiedono spiegazioni per ciò che sta accadendo nella piccola provincia, dall'altra la Serbia deve giustificare il mancato via libera ai giuristi del Tribunale Penale Internazionale e ai medici finlandesi per l'autopsia dei corpi, fatto che rende ancor più ambigua la sua posizione.
E arriviamo alla fase clue. Il 16 febbraio 1999 iniziano i negoziati finali al castello di Rambouillet, nei pressi di Parigi, presieduti congiuntamente dai ministri degli Esteri britannico e francese. Sono presenti i mediatori di Stati Uniti, Unione Europea e Russia. Per gli albanesi partecipano Rugova, Bukoshi e Agani per la Ldk, Thaci e Haliti per l'Uçk, ma anche Qosia, Blerim Shala e Veton Surroi. Milošević invece manda appositamente una delegazione di basso profilo, guidata da Marković e con un esponente di ogni etnia presente in Kosovo (albanesi collaborazionisti, slavi, turchi, zingari) a sostegno di quanto ripete da mesi ai mediatori internazionali, e cioè che metà della popolazione kosovara è tutto tranne che albanese. Ma la strada verso un accordo è piena di insidie. Da una parte l'Uçk non può accettare un accordo che non preveda l'indipendenza della regione, dall'altra la Serbia rifiuta categoricamente una presenza militare internazionale. L'impasse è totale. Solo un intervento diretto della Albright smuove un po' le acque. Il Segretario di Stato americano lancia un “ultimatum” a Thaci: o l'accordo o l'isolamento. Alla fine solo un emendamento al testo dell'accordo, che prevede dopo tre anni un referendum popolare sullo status finale del Kosovo, e un ulteriore rinvio di Surroi, per permettere la consultazione della popolazione e delle “istituzioni” del Kosovo, riusciranno a tenere unita la delegazione albanese. Il 18 marzo Thaci firma l'accordo. Belgrado no. Il 19 marzo i mezzi con le insegne della Kvm lasciano Priština. La Nato è pronta a colpire.
2.4 L'intervento della Nato e la guerra di Milošević
Ormai l'attacco della Nato è imminente. È una questione di giorni, se non di ore. Milošević completa le purghe ai vertici militari e dei sevizi segreti, chiaramente in vista della guerra, e invia decine di migliaia di soldati in Kosovo. Ora le forze sul campo comprendono circa 40 mila uomini e 300 carri armati. Oltre all'Armata serba vengono sguinzagliate unità speciali del governo e di paramilitari, che hanno il compito di diffondere il terrore tra la popolazione albanese. Il che comporta stragi, uccisioni, rapine e stupri, per indurre il resto degli abitanti a fuggire. Ma la bonifica etnica non è di certo cosa nuova o improvvisata. È da dieci anni che si compie sistematicamente quello che i vertici di Belgrado hanno pianificato a tavolino, semplicemente ora tutti vedono, o vogliono vedere. Quella di Milošević è una guerra nella guerra. Mentre la Nato pianifica i vari attacchi dal cielo contro la Serbia, a terra continuano le deportazioni di massa, i bombardamenti sistematici sui villaggi, lo svuotamento di paesi e città, le espulsioni verso i confini. Alle ore 19.45 del 24 marzo 1999 inizia l'attacco aereo della Nato contro la Serbia. La campagna aerea si svolge in tre fasi.
Fase uno. Si comincia colpendo bersagli strategici, come gli aeroporti, i ponti, le attrezzature, i mezzi, le postazioni e le difese aeree jugoslave. A terra l’Uçk si limita a difendere la propria gente e poche postazioni isolate. Da subito la campagna aerea rivela i suoi limiti. Infatti è praticamente impossibile riuscire a fare un vera e propria pianificazione di tutti i bersagli. Tant'è che dopo tre giorni le missioni per colpire i 91 bersagli prestabiliti erano state portate a termine e non si sapeva più cosa fare precisamente. La realtà è che la Nato ha cominciato questa guerra allo scopo di far tornare velocemente Milošević al tavolo delle trattative, ma diventerà la guerra per far tornare i profughi nelle loro case. L'Alleanza infatti si trova ad affrontare inaspettate difficoltà, sia interne che esterne. Innanzitutto cominciano i veti sui bersagli da parte dei singoli governi che devono rispondere alla propria opinione pubblica nazionale, e le manifestazioni per la pace sono sempre più pressanti. Ai livelli alti del comando militare si è acceso un aspro dibattito. Alla posizione britannica di intervenire da terra, si contrappone la proposta italiana, un po' velleitaria, di procedere con un embargo totale alla Serbia. Inoltre una gaffe di Clinton aveva già minato alla base la credibilità dell'intervento aereo. Infatti nel suo messaggio alla nazione del 24 marzo lui stesso dice:”Io non intendo mettere le nostre truppe in Kosovo”. Milošević coglie la palla al balzo. È chiaro che, senza un intervento da terra, ha maggiore libertà di azione per la bonifica etnica, provocando un esodo massiccio verso la Macedonia e l'Albania, la più grande deportazione di massa in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale. Le descrizioni dei superstiti sono agghiaccianti: esecuzioni sommarie, stupri, uccisioni di anziani e disabili che non riescono a tenere il passo degli altri. La sensazione è anche che le forze serbe si facciano scudo con queste comitive di profughi. L'Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite stima che ci siano 260 mila sfollati in Kosovo, e 200 mila tra Macedonia e Albania.
Fase due. la Nato estende gli attacchi alle truppe serbe a terra. Ma questa tattica determina anche una serie di errori. Talvolta i piloti alleati scambiano una colonna di profughi per un convoglio militare serbo. Tuttavia la stragrande maggioranza degli attacchi va a buon fine.
Fase tre. Clinton preannuncia l'attacco a Belgrado, inizialmente risparmiata, che tuttavia subisce pochissimi danni. Il 22 aprile la Nato colpisce il grattacielo di Milošević. Il 23 la sede della televisione di stato (peraltro annunciata). I morti civili a Belgrado sono in tutto 25. Questo a dimostrazione del fatto che l'Alleanza ha come nemico Milošević e il suo apparato di potere e militare, non il popolo serbo. L'offensiva continua. Il 3 maggio vengono colpite le centrali elettriche e la Serbia si trova al buio. Il 7 maggio i missili della Nato colpiscono (per sbaglio?) l'ambasciata cinese, provocando 4 morti.
Intanto la diplomazia si rimette al lavoro. La Russia preme per una soluzione definitiva. Nei primi di maggio l'ex premier russo Cernomyrdin, il vice segretario di stato americano Talbott e l'ex presidente finlandese Martti Ahtisaari si incontrano e si accordano su un testo “non negoziabile” da presentare a Milošević, il quale accetterà di ritirare le sue truppe e di far entrare i contingenti internazionali; in cambio gli sarà riconosciuta la sovranità della Serbia sul Kosovo e la sua personale permanenza al potere (nonostante l'incriminazione del Tpi dell'Aja per crimini di guerra e contro l'umanità). Siamo dunque alla fine di maggio. La situazione non sembra sbloccarsi, finché Talbott non tenta un'ultima mossa che si rivelerà essere quella vincente. Infatti decide che è tempo di puntare su un uomo nuovo, l'ex presidente finlandese Martti Ahtisaari, che si è sempre dimostrato un mediatore abile e neutrale. Iniziano subito i negoziati per un nuovo documento da sottoporre a Milošević. Alla fine, dopo un'estenuante trattativa, Eltsin dà il via libera. Ahtisaari si reca a Belgrado dove il leader serbo non può che accettare il compromesso. In sostanza l'accordo prevede l'autonomia del Kosovo, sotto un'amministrazione internazionale guidata dall'Onu (con un mandato rinnovabile), in cambio del mantenimento della provincia come parte della Jugoslavia. Il cosiddetto accordo militare di Kumanovo (dal nome della città macedone dove avviene la firma del documento) del 9 giugno 1999 impone l'immediato ritiro delle forze serbe e l'ingresso delle truppe Nato, non specificando però il ruolo della Russia.
Il 10 giugno 1999 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite approva all'unanimità la risoluzione 1244, che andrà a costituire la base giuridica della missione internazionale. Il giorno stesso il segretario generale della Nato annuncia la sospensione delle azioni militari. La guerra del Kosovo è finita. L'esito è alquanto positivo per la Nato: nessuna perdita, solo un paio di aerei abbattuti. Ma la missione più difficile per la comunità internazionale comincia ora.
3. Gli aspetti controversi della guerra e gli errori della Serbia
La prima fase della crisi kosovara si chiude dunque tra gli errori di valutazione della Serbia e le contraddizioni dell’attacco Nato. Entrambi gli aspetti costituiscono la cornice di fondo entro cui verrà costruito un progetto internazionale di stabilizzazione e democratizzazione guidata del Kosovo. Ma il controverso intervento americano, in particolare, è la premessa delle contraddizioni su cui si fonderà la missione dell’Onu, e che saranno causa del suo stesso fallimento.
3.1 I perché delle scelte politiche di Milošević
In termini politici, tralasciando per un momento l'aspetto umano della repressione in Kosovo, Milošević commise almeno tre errori gravi: il primo fu di sottovalutare la coesione interna dell'Alleanza Atlantica credendo appunto che l'efficacia dell'intervento sarebbe stata fortemente limitata dalle discordie tra i vari membri; il secondo fu di contare troppo sull'eventuale sostegno da parte della Russia; infine Milošević era convinto che gli Stati Uniti non fossero davvero intenzionati a impantanarsi in una guerra per la causa di una minuscola regione in cui non avevano interessi diretti, e che dunque di fronte a una resistenza convinta avrebbero desistito.
Tutte queste supposizioni si rivelarono errate. Primo: non solo l'Alleanza Atlantica mostrò, almeno dall'esterno, di essere un forza coesa, ma anche di essere in grado di vincere un guerra, se pur limitata, senza neanche il bisogno di mettere piede sul campo di battaglia. Secondo: la Russia non mosse un dito per andare in aiuto dei fratelli slavi. Terzo: Milošević non considerò minimamente le percezioni che le stragi potevano avere sull'opinione pubblica occidentale. Gli Stati Uniti e le democrazie europee non potevano non rispondere a violazioni così eclatanti dei diritti umani e a efferate violenze che si stavano consumando proprio nel cuore dell'Europa. Ne andava della stessa credibilità dei governi democratici.
Ma le azioni del leader serbo hanno delle spiegazioni anche dal punto di vista interno. Milošević era un populista, e in quanto tale seppe sfruttare abilmente il forte potere elettorale dei richiami nazionalistici, incentrati soprattutto sulla questione kosovara (poiché come detto era simbolo di una memoria storica molto forte). Questi sentimenti così radicali sono spiegabili alla luce di una profonda crisi politica, sociale ed economica che stava attraversando la Juogoslavia alla fine degli anni '80, dovuta appunto al declino di un regime, fondato sulla personificazione del potere (Tito), e della complessa struttura sociale basata sul miscuglio di diverse etnie, religioni e nazioni. In una situazione di crisi la tendenza è sempre quella del ritorno alle origini, al passato (anche quando non esiste). È così che ci si inventa una tradizione e una memoria storica che permettano di crearsi un'identità, e quindi di distinguersi dagli altri, da tutti coloro che non rientrano in certi schemi. Questo fenomeno prende dimensioni gigantesche nella Jugoslavia post-Tito.
Tuttavia Milošević non era un fervente nazionalista (forse lo diventa dopo per interesse), ma un abile politico, che prima si assicura il primato nel partito (Partito socialista di Serbia, SPS) grazie al suo carisma, poi il consenso popolare facendosi campione delle rivendicazioni nazionalistiche in Kosovo. Ma a lui di quel “piccolo, pidocchioso Kosovo”, come lui stesso lo definisce in un incontro con il generale Short, non gliene importa niente. Semplicemente capisce che per garantirsi il mantenimento del potere doveva agire concretamente nella provincia. Ma più il tempo passava e più sembrava che quella in Kosovo fosse una battaglia persa. Nonostante tutte le angherie e le violenze subite, gli albanesi mostravano un'inaspettata caparbietà. Successivamente emerge questo gruppo di paramilitari, più o meno organizzato, che offre alla Serbia il pretesto per agire in modo ancora più deciso, con la giustificazione della difesa dalla minaccia terroristica. Anche la guerra sarebbe servita a Milošević. L'abile statista cerca di sfruttare anche questa occasione per uscirne “pulito” agli occhi del popolo serbo, ossia come colui che non è responsabile della perdita di una provincia storica.
Tutto questo spiega le azioni e le scelte politiche di Milošević. Ma che bisogno c'era allora di mettere in atto un pulizia etnica di tali dimensioni? La risposta è semplice. Il leader serbo, se pur conscio dell'impossibilità di riprendere definitivamente il Kosovo (la sproporzione demografica era troppo evidente), di certo non si vuole “suicidare” in una guerra così impari se non ci fosse una minima possibilità di successo. In pratica Milošević voleva svuotare il Kosovo, e in parte ci riuscì (si stima che ci fossero circa 800 mila rifugiati sparsi tra Montenegro, Albania e Macedonia, senza contare il numero di morti e dispersi), per mettere la Nato di fronte a un fait accompli, cioè che effettivamente in Kosovo gli albanesi non fossero in gran maggioranza. Alla fine, però, i motivi della resa non sono ben chiari. Possiamo eventualmente fare delle supposizioni su quelli che sembrano essere i più plausibili. Secondo il ragionamento di Dana H. Allin quattro fattori hanno influito maggiormente. Primo, il fatto che Milošević fosse accusato dall'Aia di crimini di guerra rendeva difficile per la Nato accettare un compromesso che lo favorisse troppo; secondo, la Russia ormai premeva troppo per un soluzione definitiva, sempre meno propensa ad appoggiare le disastrose scelte politiche di Milošević; terzo, gli ultimi attacchi a infrastrutture civili (linee elettriche, ponti), che andavano a danneggiare direttamente il cittadino medio, stavano cominciando a creare dissenso tra la popolazione, sempre meno disposta a sostenere i sacrifici imposti della guerra; quarto, e forse più importante, cominciavano ad arrivare segnali per un ormai probabile attacco da terra, cosa che a un certo punto sembrava inevitabile per la Nato.
Alla fine, con la resa, la Serbia perderà comunque il controllo su una parte del suo territorio, ma nonostante questo Milošević rimane al potere ancora per un anno, spodestato solo con le elezioni dell'ottobre 2000 dalla volontà della gente, che non ce la fa più a vivere in una costante recessione e crisi economica e con un standard di vita sempre più da Terzo Mondo.
3.2 Tra unilateralismo e diritto internazionale: aspetti giuridici dell'attacco Nato
La campagna aerea della Nato merita delle considerazioni a parte. In particolare andiamo ad analizzare alcuni aspetti: l'evoluzione dell'approccio militare, l'unicità dell'attacco aereo, la legittimità secondo le norme internazionali, e infine potremo stabilire se l'intervento sia stato o meno un successo, e in quale ambito.
In primo luogo è bene ricordare, anche se sembra banale, come l'Alleanza Atlantica sia ancora oggi (2008) una realtà tutt'altro che finita, anzi ,dopo vent'anni dalla fine della Guerra fredda, come abbia dimostrato una grande capacità di adattamento al nuovo contesto internazionale. Cosa che era ancora più evidente nel 1999. La Nato, creata appunto come strumento militare dell'Alleanza ben cinquant'anni prima, inizialmente svolgeva il ruolo di forza di sicurezza in un teatro europeo, essenzialmente in funzione anti-sovietica e con un approccio prettamente difensivo. Con il dissolversi dell'Unione Sovietica molti si aspettavano che venisse meno il motivo della sua stessa esistenza. Tuttavia non solo continuò a esistere, dimostrando la volontà degli alleati di mantenere un'importante alleanza strategica di carattere politico-militare, ma cominciò un processo di evoluzione e riorganizzazione interna. Le sue missioni comprendevano scenari sempre più diversificati e lontani dall'Europa, in svariati contesti e a diversi gradi di conflittualità. Le forze Nato erano sempre più impegnate in missioni di peace-keeping e peace-enforcement. L'Alleanza dimostrava di essere molto più unita e coesa di quanto si pensasse (per questo Milosevic sbagliò nel fare i suoi calcoli), e di voler portare dei princìpi che andassero oltre la mera opposizione militare all'Unione Sovietica. La “nuova” Nato rappresentava le volontà congiunte dei suoi membri di contrastare qualsiasi minaccia alla pace e alla sicurezza della società internazionale, ovvero laddove venissero lesi gli interessi di uno dei suoi membri. Il famoso art.5, che prevede l'intervento di tutta l'Alleanza in caso di aggressione contro uno o più dei suoi Stati, veniva in un certo senso superato, ampliando la possibilità di agire anche senza uno specifico mandato internazionale.
In secondo luogo l'intervento della Nato ha aperto un acceso dibattito in campo giuridico sulla sua legittimità secondo le norme, convenzionali e consuetudinarie, del diritto internazionale. L'articolo 2.4 della Carta delle Nazioni Unite afferma chiaramente che “i Membri[gli Stati che hanno sottoscritto la Carta] devono astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza nelle loro relazioni”. Questo articolo rappresenta una regola cogente e perentoria valida sempre e comunque. Ma la stessa Carta pone un'eccezione a tale regola, espressa dall'articolo 51, ossia la possibilità di usare la forza in caso di difesa individuale o collettiva, e ampliata dall'articolo 53 a organizzazioni regionali, le quali possono essere autorizzate dal Consiglio di Sicurezza ad intraprendere azioni di natura coercitiva. Il CdS, ai sensi del Capitolo VII della Carta, deve agire da garante della regola, cioè eseguire funzioni di “accertamento dell'esistenza di minacce alla pace, violazioni alla pace, o un atto di aggressione”. Dunque in caso di necessità il Consiglio di Sicurezza è l'unico organo delle nazioni Unite legittimato a intraprendere delle contromisure in funzione della situazione, come previsto ai sensi degli articoli 40, 41 e 42. Ma allora l'intervento della Nato è legittimo secondo le norme del diritto internazionale? La difficoltà nel rispondere a questa domanda denota tutta l'ambiguità e incompletezza del sistema giuridico internazionale. In effetti la Nato, e gli Stati Uniti in primis, non hanno avuto il via libera ufficiale da una risoluzione del Consiglio di Sicurezza (come abbiamo visto la Russia in quanto membro permanente avrebbe posto un veto, e lo stesso la Cina) ma ha invocato la necessità di intervento in nome del diritto umanitario. Ossia un intervento necessario a contrastare una evidente situazione di minaccia alla pace, di crimini contro l'umanità e addirittura di genocidio (cioè una serie di violenze sistematiche e organizzate secondo criteri di tipo razziale, religioso, etnico, nazionale). Viene dunque elaborata questa nuova dottrina dell'intervento umanitario, tra l'altro anche rifiutata da alcuni esperti. Nuova perché in effetti non ci sono ancora norme consuetudinarie che annoverino questa categoria tra le possibili legittimazioni ad un intervento armato, né secondo un criterio oggettivo (usus o diuturnitas), ossia l'esistenza di una prassi generalizzata e diffusa, né secondo un criterio soggettivo (opinio juris ac necessitatis), ossia la convinzione da parte degli Stati che quella prassi corrisponda a diritto o sia dettata da necessità sociali, economiche o politiche.
Però la legittimazione dell'iniziativa della Nato sembra arrivare ex post, con la risoluzione 1244 che in effetti prende atto del fait accompli, ossia l'occupazione di una parte del territorio di uno Stato sovrano, cioè la Serbia, aggiungendo tra l'altro che è necessario prolungare tale occupazione tramite l'istituzione di un'amministrazione provvisoria sotto forma di protettorato internazionale. Dunque l'intervento della Nato in Kosovo potrebbe rappresentare un precedente anche in questo senso. Non solo, come già detto, così facendo si dà il via a una missione costruita su basi giuridiche controverse, destinata al fallimento.
In terzo luogo possiamo affermare che la campagna aerea in Kosovo è unica anche dal punto di vista militare. Per la prima volta nella storia una guerra viene vinta senza il dispiegamento di forze sul campo, ma solo con attacchi dal cielo. Le perdite dell'Alleanza sono state pari a zero, escludendo i due velivoli abbattuti. Inoltre la novità va individuata anche nella natura delle forze in campo. Nella vicenda kosovara si vengono a contrapporre uno Stato e un'organizzazione regionale multinazionale. Se pur con un'evidente supremazia interna da parte degli Stati Uniti, la Nato ha cercato di agire sostanzialmente come una forza unica e compatta, riunendo e coordinando le volontà dei suoi membri, e il risultato è stato abbastanza positivo.
Per finire cerchiamo di tirare le somme di questa guerra. Dal punto di vista politico è stata di sicuro un successo. Come detto, l'Alleanza ha dimostrato al suo interno un inaspettato grado di coesione, e soprattutto i governi avevano la percezione di reale controllo sulle operazioni militari (poco importano le eccezioni), dato che l'intera campagna era stata approvata dal Consiglio atlantico. Dal punto di vista militare invece la campagna aerea si potrebbe definire un “non successo”. Infatti oltre agli errori di precisione, che avrebbero causato la morte di alcuni civili, bisogna considerare che, nonostante l'enorme impegno bellico messo in atto, le forze alleate non siano riuscite nel loro vero intento, cioè la deterrenza. E questo vale sia prima che durante la guerra, che è durata fin troppo data l'enorme sproporzione di mezzi a disposizione. E da ultimo, ma non per importanza, l'attacco della Nato non ha fatto che accelerare e intensificare la pulizia etnica, che rappresentava il motivo dell'intervento stesso. Insomma, come giustamente fa notare Garimberti, sembra essere proprio una vittoria di Pirro.
È evidente, tenuto conto di tali considerazioni giuridiche, come la crisi del Kosovo confermi un fatto evidente nelle relazioni internazionali, cioè che formalmente tutti gli Stati sono uguali ma sostanzialmente alcuni sono più uguali degli altri. Dunque l'intervento della Nato, per quanto giustificabile dal punto di vista etico, formalmente viola le norme internazionali andando a costituire un'azione unilaterale da parte degli Stati Uniti che utilizzano l'Alleanza Atlantica come strumento di legittimazione multilaterale.
Le controverse giustificazioni per l’intervento e i dubbi risultati ottenuti dalla guerra fanno sì che la stessa missione dell’Onu che ne deriva si fondi su delle basi instabili, compromettendone la riuscita. L’intervento della Nato costituisce motivo di tensioni nella comunità internazionale, non ancora sopite dopo dieci anni. Dunque anche le controversie giuridiche sulla campagna aerea vanno a inserirsi tra le cause del fallimento della missione internazionale.